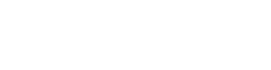Se si eccettuano le bibliche foglie “indossate” da Adamo ed Eva nell’Eden, il primo abito fu indubbiamente una pelle di animale, che all’inizio fu usata intera, al naturale, ma che poi venne, secolo dopo secolo, sempre più lavorata, adattata alle membra e confezionata. Le pelli nelle primissime civiltà hanno avuto un ruolo assai importante, connesso al loro valore commerciale già allora notevole: non per nulla una delle parole con le quali oggi si definisce il denaro, “pecunia”, deriva da “pecus”, termine latino che indica il bestiame in genere (da cui l’italiano “pecora”), le cui pelli venivano usate come merce di scambio e come denaro. Ancora oggi pelliccia significa denaro, rimasta per secoli privilegio pressoché assoluto dei sovrani, della nobiltà e del clero, però negli ultimi decenni, grazie al diffondersi del benessere, la pelliccia si è trasformata, per molte donne, da sogno in realtà. Una realtà nella quale, a dispetto della civiltà consumistica e industriale che stiamo vivendo, la pelliccia non ha perduto assolutamente nulla del suo fascino, del suo prestigio, delle sue caratteristiche esclusivamente artigianali. Già nella Roma antica le pellicce non rispondevano più al solo scopo di proteggere dal freddo e dalle intemperie, ma erano usate con intenti di eleganza e di lusso, erano già state cioè aggiogate al carro della moda. Ovidio parla di “pellibus tecta tempora”, cioè di berretti e cappellini pelo, mentre nelle commedie di Plauto vi sono personaggi che esercitano l’arte del pellicciaio e in altri autori classici si cita spesso la”pellis manicata”, cioè la pelliccia provvista di maniche. Si ricorda anche l’espressione “sub pellibus” (cioè “sotto le pelli”) che stava ad indicare il servizio militare, in quanto la copertura delle tende negli accampamenti dei soldati era formata da pelli di animale. Senatori, patrizi e mogli degli altolocati romani furono i grandi clienti dei pellicciai di quell’epoca, e i mercanti avevano il loro da fare perché i capi più pregiati provenivano dall’Africa (le pelli di leopardo erano le più costose) o dalla Germania, forniti da quelle stesse popolazioni che assediarono poi Roma imperiale. Immancabile elemento del guardaroba maschile e femminile, la pelliccia conoscerà i suoi trionfi tra i grandi capi di quelle genti e caratterizzerà tutto il Medio Evo. Carlo Magno nelle cerimonie ufficiali vestiva abiti foderati di volpi, di vajo (l’attuale petit-gris) e di ermellino, ma poi, preoccupato dal costo di questi indumenti, sarà lui stesso ad emettere per primo severe leggi imponendo dei prezzi massimi di vendita per le pelli di lontra e martora.
La voga delle pellicce stava esplodendo nell’intera Europa: se ne accorsero alla Corte di Bisanzio, quando i Crociati vi fecero tappa nel 1096, coperti di tutto punto dalle pellicce più preziose; il solo Goffredo di Buglione ne aveva addosso per un valore inestimabile.
A Parigi nel 1272 si contavano nella sola città ben 214 pellicciai e l’uso si andava estendendo gradatamente a tutte le classi sociali, cosicché perfino i poveri ricevevano pelli in elemosina, insieme al cibo indispensabile per sopravvivere. Nel 1127 viene interdetto alle monache l’uso di pellicce; fu un concilio a stabilirlo. Anche l’Italia visse quest’epoca d’oro della pelliccia; a Milano già nel Medio Evo si formò la “Corporazione dei Vairari e Pelizari” riservata ai commercianti e agli artigiani della pelliccia; per esservi ammessi era necessario sostenere alcune complesse prove tecno-pratiche. Intorno alla Corporazione si sviluppò l’abilità artigianale destinata a perfezionarsi ed arricchirsi nel tempo, e ruotarono interessi sempre più vasti, collegati al commercio delle pellicce. Benché statuti e regolamenti concedessero soltanto ai nobili, ai cavalieri e ai dottori il privilegio di portare guarnizioni di pelliccia, se ne impose l’uso come principale elemento di eleganza e di fasto.
In quell’epoca erano in voga specialmente l’ermellino, il vajo, lo zibellino e lo scoiattolo. A Firenze, le donne usavano portare ampi mantelli foderati di martora e di zibellino; (la nobildonna Caterina Pucci vantava una gonnella in pelliccia di leone valutata quattro fiorini ed un’altra martora acquistata per ventiquattro fiorini; Bianca Maria Sforza Visconti andò sposa ad Alfonso d’Este portando in dote un ricchissimo guarda roba di pellicce). A Venezia il Doge e la Dogaressa erano gli arbitri dello sforzo cittadino: lui nelle cerimonie portava un manto d’oro foderato di pelliccia e un rocchetto di ermellino bianco; lei sognava una veste di broccato foderata di ermellino con un lunghissimo strascico. Tiziano Vecellio, ottimo cronachista oltre che pittore, scrisse cosi della moda veneziana di quei tempi: “intorno al principio di novembre i nobili si mettono la veste di ermellino che si porta sciolta e indossano quella foderata di pelli che si cinge con la cintura di velluto e che ha fibbie d’argento. Ma poiché quelle pelli sono assai leggere, quando si accresce il freddo si cambiano pelli e si mettono quelle più gravi e da tenere più caldo. Le dame sopra la camicia portano la corpetta, la quale è di broccatello e d’inverno si fodera di pelli preziose. In questo tempo d’inverno usano ancora una manizza foderata di pelli con la quale difendono le mani dal freddo”. Sempre in quell’epoca, è di gran moda il “pelliccione”, portato sia dagli uomini che dalle donne, che è in realtà una vera e propria pelliccia simile a quella moderna; per le donne è lunga fino al ginocchio, orlata di ermellino e di vajo, ha spesso maniche larghe e lunghissime, e munita di un cappuccio a gola e viene portata per cavalcare; per gli uomini è in genere attillata alla vita, si allarga ai fianchi in pieghe profonde; spesso è lunga fino ai piedi ed ha un ampio collo che circonda il viso come un calice; le pelli impiegate variano secondo le possibilità economiche, ma i tipi più diffusi sono la lince, la volpe o il leone. A Genova le navi che attraccavano al porto favorirono il commercio delle pellicce. (Gli archivi della città parlano spesso di questa moda: ecco, per esempio, come si lavavano le offese: “Nel 1214 Giordano delle isole, avendo insultata, percossa e intaccata nell’onore certa Giustetta, per riparare al malfatto, promette, mediante atto legale esteso al notaio Pietro Ruco, di regalare all’offesa una bella pelliccia e quindi una ricca veste foderata di pelli di coniglio…”. Anche a Genova le leggi “suntuarie” perseguitavano l’eccessivo sfoggio di pellicce di valore: ogni sposa non poteva avere nel suo corredo più di due pellicce di vajo, un manto foderato e un manto di pelli).
D’inverno era permesso portare al collo pelli di volpe, di faina, ma non di ermellino, riservato esclusivamente ai notabili, agli ambasciatori, ai grandi cittadini inviati in legazione al Papa o ai re o agli imperatori, agli ecclesiastici di alto linguaggio. Ma ecco quello che venne stabilito, sempre a Genova nel 1613: “Si proibisce alle donne si portare … in qualsivoglia maniera pellicce di zibellino in roba anche per fodera di veste”. E la pena in caso di trasgressione? “Le donne, per la prima volta, abbiano la pena di forestazione, restino chiuse in casa tre mesi, e quattro la seconda, non possino in questo tempo ricevere visite, fuorché di parenti di primo grado sotto pena di scudi venticinque o cinquanta, anche a chi farà visita; ogni una delle inosservanti dovrà apportare anche la spesa giornaliera di quattro soldati posti a guardia della rispettiva casa”.
Davvero un sistema originale per punire i peccati di vanità, che, tuttavia, erano benevolmente concessi alle sposine novelle le quali, per soli quattro giorni dopo il matrimonio, potevano sfoggiare pellicce di lusso senza incorrere in nessuna pena.
Gli immensi guadagni accumulati dai pellicciai in questi secoli non andarono però tutti a finire nelle loro casseforti. Essi erano tenuti a dare sostanziosi contributi, e li davano volentieri, alle opere di interesse pubblico, e specialmente alla Chiesa. La costruzione delle più belle cattedrali d’Europa è dovuta anche alle notevoli offerte dei pellicciai. Nel Duomo di Chartres, nelle stupende vetrate che illustrano la vita, di Carlo Magno, appare un commerciante di pellicce che offre la sua mercanzia; una scena analoga e riprodotta nelle vetrate della primaziale di Bourges. E così, a dispetto di tutte le leggi restrittive (a Firenze si giunse anche a permettere alla dame l’uso di pellicce di lusso solo a condizione che fossero marcate dal Governo, dietro pagamento di una tassa piuttosto pesante), la pelliccia conobbe lunghi secoli di successo, dimostrando ancora una volta che il gusto e il lusso possono essere considerati più forti delle stesse leggi dello Stato.Nel secolo XVII il manicotto, citato da Tiziano, diventa di gran voga e utilizza e utilizza le pelli più pregiate, mentre nel secolo successivo gli abiti femminili molto eleganti hanno alti bordi di pelliccia; in Inghilterra vanno di moda mantelli di seta con altissime balze di volpe da accompagnare ai grandi manicotti.Nel corso del 1800 il commercio delle pellicce può finalmente approfittare di quella e propria miniera costituita dal Nord America, si hanno manti foderati di ermellino, ricche guarnizioni in fondo ai mantelli, baveri, mantelline, profilature di pellicce preziose; le balze di pelli coprono ormai circa la metà della sottana; sono di voga grandi mantelli foderati e guarniti di lontra e castoro; le guarnizioni si moltiplicano in due o addirittura tre bordi di pelliccia; la martora e l’ermellino sono diffusissimi. L’apice è stata raggiunta poi a metà del 1800, poi l’uso della pelliccia scenderà e si rifà viva nel 1900.
La prima metà dell’ottocento vede quindi la massima diffusione delle pellicce, che vengono abitualmente indossate da uomini e donne in una frenetica corsa all’eleganza e al lusso. Il merito è in gran parte delle enormi quantità di pelli che giungono dai futuri Stati Uniti e dal Canada.
Già nel 1670 in realtà era nata a Londra la “Hudson’s Bay Company”, una compagnia che vive ancora oggi e che al momento della fondazione ottenne dal re d’Inghilterra Carlo II il monopolio del commercio delle pellicce nelle regioni che circondano lo stretto e la baia di Hudson in Canada, una zona nella quale le condizioni climatiche sono favorevolissime alla vita degli animali da pelliccia.
Un’altra società specializzata nel commercio delle pelli da pelliccia nell’America settentrionale fu la “North West Company”, sorta nel 1783, diretta concorrente della Hudson’s Bay Company, dalla quale fu poi assorbita nel 1821.
Altre due grandi compagnie commerciali raccoglievano e inviavano verso i due principali mercati di consumo (Europa e Stati americani dell’atlantico) migliaia di balle di pelli di castoro l’anno, ovvero: la “Compagnia pellicce del Missouri” fondata nel 1800 da Maniel Lisa e la “Compagnia pellicce delle montagne rocciose” creata nel 1830 da Thomas Fitzpatrik.
Un altro “impero” delle pellicce era frattanto sorto anche in Asia, più precisamente in Siberia. L’iniziativa fu presa dalla famiglia russa degli Stronganov, che già nel sedicesimo secolo aveva intrapreso commerci al di là degli Urali incontrando ostilità delle popolazioni locali poi debellate dalle truppe inviate dallo Zar.
Nei primi anni del XVII secolo lo sfruttamento delle pellicce siberiane era avviato: le popolazioni sottomesse (tra di esse Cosacchi e i Tartari) pagavano i loro tributi in pellicce e tutto l’immenso territorio divenne una vera e propria miniera di quella preziosa mercanzia che frattanto era giunta all’apice dell’eleganza presso la corte imperiale di Pietroburgo. I commercianti russi di pellicce si spinsero nella loro conquista fino lo stretto di Bering superandolo e raggiungendo l’Alaska e penetrandolo così nel continente americano dove fondarono compagnie commerciali insieme agli americani.
Agli inizi del novecento, la pelliccia, che aveva sofferto un certo calo di popolarità nella seconda parte dell’ottocento, tornò di gran moda e da allora non ha mai subito minima crisi.
Nella “belle époque” la moda utilizzava le pelli per mantelline a campana, giacchette, pellicce complete, in una gamma di qualità, di fogge, di impieghi classici e anticonformisti davvero infinita che si è evoluta man mano con maggior fantasia.
In realtà la pelliccia fin dalla metà ottocento poteva contare su tutta una serie di innovazioni tecniche: Ermellino, zibellino e martora godono, in questo periodo, di gran popolarità (o almeno di gran desiderio). Furoreggia la lontra di mare, si impiega largamente il rat-mousqué ed il lapin, si può dire che fra moda e pellicceria è avvenuto lo storico abbraccio. In questo periodo la pelliccia marcia a suon di colli e bordure, manicotti per signore in particolare di ermellini e martore; si arricchisce l’abito ma si ignora la moda.
Vi sono lunghi mantelli che, interpretando la moda dell’epoca, vantano ricami preziosi sia su inserti centinati in cuoio o sul collo, sia direttamente sulla pelliccia. Sono proposti in lontra, Karakul, breitschwantz, astrakan e possono essere bordati, a scelta di visone del Canada, chinchillà o zibellino.
Capi di questo genere sono naturalmente rivolti, a quell’epoca ad un élite di signore che costruiscono con pazienza il proprio guardaroba in atelier, consultando i cataloghi più eleganti, interpretano e seguono attentamente la cronaca mondana riccamente illustrata sui giornali di moda dell’epoca, come Les Modes, La Gazette du Bon Ton, Fèmina, Wiener Mode.